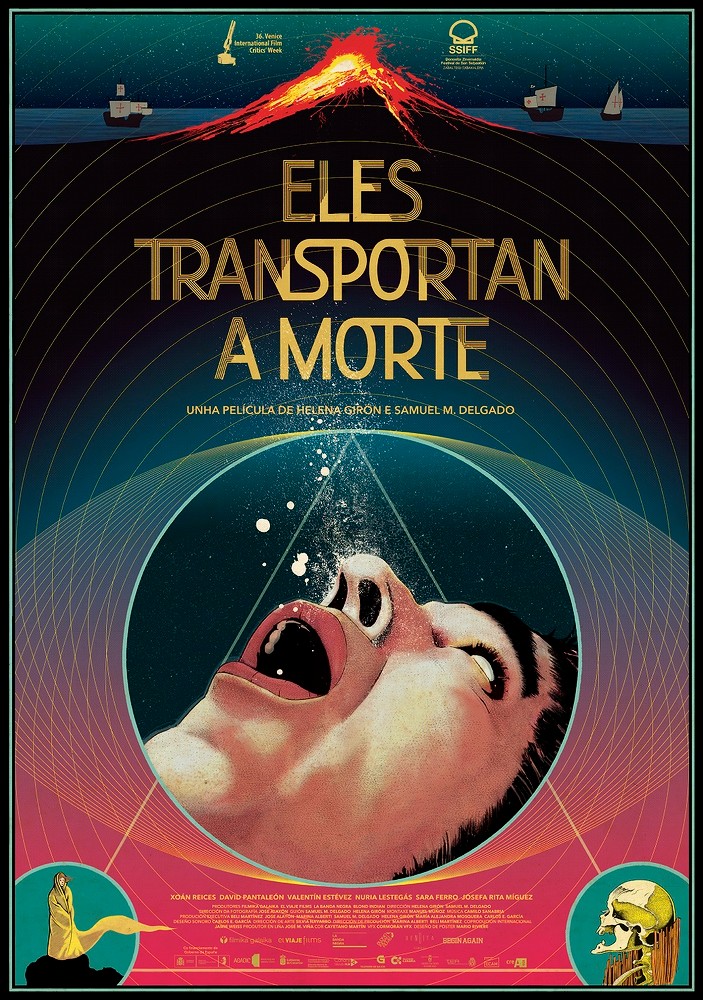Film lungo, lunghissimo, estenuante, parlatissimo, una fatica. Ma una di quelle fatiche che portano a qualcosa, una di quelle fatiche che non sono la conseguenza di ma il metodo per.
La storia di un regista teatrale imprigionato in una rettitudine morale e in una incapacità di reazione quasi patologica.
Un film probabilmente sul controllo, sulla necessità di avere controllo, sulla necessità di dover guidare la propria macchina perchè si è convinti che soltanto se la si guida da soli possa funzionare. Ma, come nella vita, non è vero, come nella vita a volte serve un autista esterno per farti capire che quella macchina, che quell'anima, può avere anche una guida diversa, e forse salvifica.
Ma Drive my car è anche una grande opera sulla commistione tra vita e teatro, sulla necessità di liberarsi dai ricordi, sulla verità o rappresentazione dei sentimenti, sulla dicotomia tra voce e silenzio e sulla paura di cambiare percorso.
Perchè a volte solo cambiandolo ci si può ritrovare
Primo film che vedo di Hamaguchi, uno di quei registi cult giapponesi che alla fine, vuoi uno vuoi l'atro, qualcuno ne manca sempre all'appello.
Primo film che vedo di Hamaguchi, uno di quei registi cult giapponesi che alla fine, vuoi uno vuoi l'atro, qualcuno ne manca sempre all'appello.
In realtà vedo che la sua filmografia è piuttosto esigua e recentissima, mi sento meno in colpa.
Non sapevo niente del film tranne che durava uno sproposito (3 ore) ed è parlatissimo (confermo).
Tolgo subito un dubbio a chi si(mi) chiederà: "Oddio, 3 ore, troppo, ma non è stancante?"
Sì, è stancante, e sì, è troppo.
Ma non solo si arriva alla fine senza morire sulla poltroncina, non solo paradossalmente nel finale arrivano anche più forze di prima ma, e questo vale nel cinema come nella vita, bisogna ricordare che ci son cose che costano fatica, che devono costare fatica, cose in cui la fatica non è la conseguenza del percorso ma una delle componenti principali dello stesso, se non c'è lei allora non vale, allora non serve.
E' un film colto, possiamo dire tranquillamente "troppo" colto, nel senso che è una di quelle opere per cui in base a quanto uno ne conosce bene i riferimenti (Murakami, Cechov) allora può prenderne di più o di meno, come se un film alla fine possa essere paragonato ad una scodella di riso dalla quale ognuno di noi, con cucchiai di grandezza diversa, può attingere in maniera diversa.
Il cucchiaio che avevo io per Drive my car era un piccolo cucchiaio (Cechov per me è una lettura adolescenziale rimasta fuori dai ricordi) ma per fortuna non piccolissimo vista la mia buona frequentazione con Murakami.
E sì, in ogni frase di Drive my car, in ogni personaggio, in ogni conflitto, in ogni mistero sembra di leggere le pagine di Murakami. Son personaggi profondi e verbosi, sempre che un personaggio possa essere verboso non per quanto parla ma per quanto per costruirlo bisogna parlar di lui. Personaggi che hanno sempre qualcosa nel passato che li attanaglia, a volte cose piccole che Murakami fa diventar macigni, a volte macigni che non possono non esser tali.
E sì, in ogni frase di Drive my car, in ogni personaggio, in ogni conflitto, in ogni mistero sembra di leggere le pagine di Murakami. Son personaggi profondi e verbosi, sempre che un personaggio possa essere verboso non per quanto parla ma per quanto per costruirlo bisogna parlar di lui. Personaggi che hanno sempre qualcosa nel passato che li attanaglia, a volte cose piccole che Murakami fa diventar macigni, a volte macigni che non possono non esser tali.
Yusuke è un regista e attore teatrale. E' famoso nel suo ambiente, molto conosciuto, anche se non pare navigare nell'oro (questo è il teatro) e gira ancora da 15 anni con una Saab rossa che diventerà personaggio principale del film, come se le ruote fossero gambe, la carrozzeria pelle e gli interni l'anima.